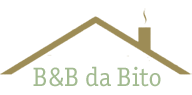I TESORI DI DIOMEDE di Folco Quilici
Quanto nascosto nell’isola dove sto per condurvi, potrebbe essere un tesoro vero, monete, oggetti d’oro, gioielli. Lo preciso perché quando si cita un’isola mediterranea, vien spontaneo definirla un “tesoro” per la rarità delle sue bellezze. No. Narrandovi di San Nicola, nel microarcipelago delle Tremiti, parlerò di veri e propri tesori. E mi riferirò a eventi reali di pirateria in conseguenza dei quali molti beni preziosi vennero laggiù nascosti.
La piccola, calcarea San Nicola è dominata da un’imponente fortificazione; mura e pareti rocciose di un edificio un tempo ritenuto difficile da espugnare. Faticoso oggi da visitare, salendo dal mare sino ai suoi livelli superiori.
Ho affrontato la lunga scalinata protetta da spalti e merli verso l’imbrunire, passo a passo, sino alle costruzioni interne, sfiorando pietre dove sono impastati dieci secoli di storia. Parti d’una colossale opera artificiale resa imprendibile anche dalla natura: anche pareti di roccia, a strapiombo sul mare furono tagliate verticalmente per proteggere la fortezza da possibili assalti alle spalle. Occorreva difendere quanto qui veniva accumulato. Ricchezza di saccheggi ma anche donazioni ottenute in cambio della
protezione offerta a ricche famiglie delle rive pugliesi.
Pirati saraceni e dalmati nel miraggio di questi beni, s’accanirono nel tentativo d’espugnare l’isola-fortezza che al centro dell’Adriatico meridionale non difendeva solo beni in pericolo, ma anche popolazioni minacciate non solo dai furti dei saraceni, ma anche dalla loro caccia a schiavi da razziare tra i miscredenti cristiani.
I castellani non si limitarono tuttavia ad azioni di difesa. In un lungo e fosco periodo anch’essi compirono azioni di pirateria verso porti, mercati, navi da trasporto. Accumulando altre ricchezze.
Strana categoria di pirati, quella di base a San Nicola: erano monaci benedettini! Nel 1045, provenendo da Montecassino, essi avevano creato un primo monastero sull’isola, attorno alla cappella edificata nel 311 da un eremita; da allora in poi, di anno in
anno, avevano però trasformato l’Abbazia, mutando anch’essi nel tempo. Da aggregazione di gente pia a banda, tanto arrogante e ricca da pretendere l’autonomia dall’Ordine. Delirio di potenza che non poteva non preoccupare la Chiesa, anche perché attendibili voci continuavano a diffondersi su azioni più da fuorilegge che di carità; e di alleanze con i dalmati non tanto per difendersi dai turchi ma per assaltare qualunque naviglio da trasporto.
Fosca epopea che si concluse tragicamente nel 1343, quando i monaci vennero tutti trucidati da corsari slavi. Erano riusciti a far entrare nell’Abbazia inespugnabile una bara, implorando benedizione e degna sepoltura cristiana ad un compagno defunto. In quella bara avevano nascoste armi; e una volta in chiesa, all’interno delle mura, gli assaltatori, spade e coltelli in pugno, avevano compiuto la strage e razziato tutto. Forse, però, non l’intero tesoro. Secondo cronache che molti ritengono attendibili, i corsari sterminatori non riuscirono a trovare quanto giaceva in nascondigli sotterranei.
Non è un caso, quindi, se da quando le Tremiti tornarono a popolarsi anni dopo l’eccidio, sbarcano a San Nicola numerosi e accaniti cacciatori di tesori. Che non hanno mai smesso di scavare, di cercare. A mio avviso un tesoro esiste, alle Tremiti. Non è, però, una cassa di gioielli o di monete d’oro. E’ di ben diversa natura.
Nasce dal mito dell’eroe omerico Diomede. Di lui narra Omero che dopo la morte di Achille nessuno, sotto le mura di Troia, lo emulava per valore e coraggio; fu nel ventre del cavallo di legno, il finto ex voto dell’astuto Ulisse che permise ai greci di penetrare e distruggere l’irriducibile città nemica.
Per quanto forte e astuto, Diomede quando tornò in patria fu però vittima, come Agamennone, del tradimento ordito dalla moglie. Scampò alla morte e fuggì dalla sua patria per fondarne un’altra, cercandola lungo le rive dell’Adriatico, nel “paese del tramonto”, l’Hesperia (quell’Italia ancora “terra incognita”). Come per molti eventi leggendari, anche il viaggio di Diomede nel nostro mare ha un fondamento reale. Interpretando varie fonti antiche, gli studiosi d’oggi leggono le leggendarie avventure del viaggio di Diomede, come un riflesso delle rotte dei greci micenei lungo l’Adriatico. Una pagina di storia reale sulla quale si innestò la favola di un eroe.
Il suo epico viaggio si concluse quando la sua imbarcazione naufragò alle Tremiti e Diomede venne sepolto con i compagni alle Tremiti. Secondo la leggenda Afrodite, la divina protettrice dell’eroe, tramutò i suoi compagni in uccelli di mare; sono le diomedee, “berte maggiori” che nidificano nella costa, tra le rocce delle Tremiti. Il loro canto, asserivano i cantastorie antichi, doveva ricordare Diomede, ai navigatori che bordeggiano l’arcipelago. E con lui ricordare anche compagni, destinati a vegliare sulla sua tomba con canti notturni. Leggenda profondamente radicata, non solo perché nell’isola esiste effettivamente una arcaica tomba greca, a tholos, detta “di Diomede”, ma perché in quei pressi il silenzio di ogni sera estiva è rotto dalle “strida acute” levate dagli stormi di berte maggiori. Autori come Plinio, Ovidio, Strabone chiamavano le avis diomedea quell’uccello e assieme ad altri autori classici riferivano tutti di quel lugubre, notturno grido e lo interpretavano come “un pianto”.
Colonna sonora invariabile di una favola immortale. Echeggia nelle notti di primavera, nel tempo in cui le berte covano le loro uova. Soprattutto in quelle settimane si alza nel buio il loro concerto inconfondibile. Per noi un misterioso canto corale, per loro singoli messaggi sonori di scambio, tra maschi e femmine. Al momento del ritorno all’isola dopo la caccia in mare, il maschio cerca d’orientarsi; e la femmina, già a terra per covare le uova, risponde al richiamo del partner per guidarlo come con un radar al nido. Invisibile, nell’oscurità. Per quanto ancora? Le “diomedee” sono in pericolo anche se nel Mediterraneo arrivano ogni primavera in più di centocinquantamila dall’Africa.
Nel loro lungo, faticoso viaggio migratorio, affrontano non solo continui cambiamenti di condizioni meteorologiche, ma soprattutto l’insidia che cresce di anno in anno: la “posta” dei cacciatori. Molti sono africani, ma ancora di più sono gli europei, che uccidono non per fame ma per divertimento. Solo lungo le coste maltesi al momento del “passo” vengono uccise oltre
duemila berte. La strage si moltiplica con la caccia praticata in molte altre isole mediterranee. In non poche, gli abitanti hanno per di più l’abitudine di cibarsi delle loro uova, quando le berte si posano per la cova durante il periodo estivo. Solo a Linosa, dove si è compiuta una ricerca nell’arco di molti anni, gli isolani ne raccolgono dalle duemila alle quattromila. Altrove, le berte vengono uccise anche per prelevare alcune particolari penne da usare come esche per la pesca. Alle Tremiti la loro colonia per ora è salva. Poco lontana dai nidi, quella tomba sia o non sia quella dell’eroe Diomede, ci tramanda un gioiello canoro altrove ferito e disperso.
Il canto quasi umano di un popolo alato, ripetuto qui da migliaia di anni. Un tesoro di suoni sempre più raro, unico al mondo.
Folco Quilici